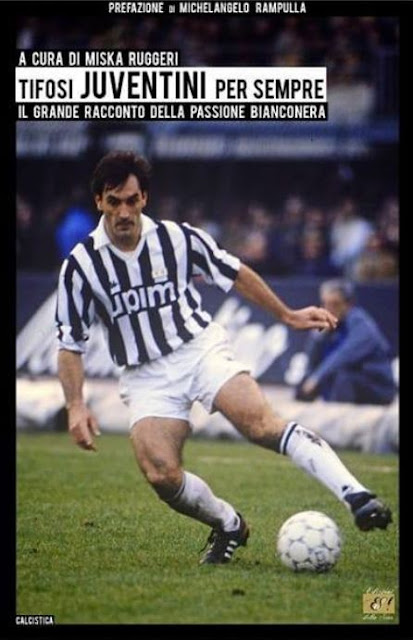Da Libero del 26 ottobre 2016
Postfazione di Mattias Mainiero
Era
sprofondato in una poltrona della hall del Grand Hotel di Roma. Sul tavolino,
una pila di giornali. Altri giornali per terra. Sapevo che nessun cameriere o
direttore avrebbe potuto chiedergli di raccogliere quei giornali, o
raccoglierli di persona. Si sarebbe sentito rispondere che il tavolino era
troppo piccolo, che con un tavolino così piccolo non si poteva lavorare, che il
Grand Hotel era in decadenza. Nessun cameriere o direttore si fece vedere nei
paraggi. Parlammo per un’oretta, ma parlammo è una parola grossa, sbagliata.
Con Nino
Longobardi non si parlava. Si ascoltava. E così quella che doveva essere
un’intervista divenne un racconto, il suo. La sua Torre del Greco, il suo
Messaggero, il suo giornalismo, la sua inchiesta, la sua discesa in campo come
politico. Quella volta in cui lui, qualche anno prima, aveva deciso che io
dovevo fare il giornalista. Non era andata così: parti invertite, ero io che
avevo chiesto a lui di poter scrivere, lui quello che aveva risposto che il
giornalismo era morto, che non conveniva più, che dovevo scegliere un’altra
strada. Ma con Nino Longobardi non si poteva parlare di giornali ai piedi del
tavolino, e neppure di fatti oggettivi, inoppugnabili. Nella realtà lui vedeva
sempre cose diverse, cose che gli altri non vedevano. Se non le vedeva, se le
inventava. Odiava la banalità, la routine, il già detto, già fatto, già visto.
Una volta
scrisse un articolo su un fatto di cronaca. No, per la verità, non lo scrisse,
lo dettò, come spesso faceva, a un correttore di bozze, pur avendo dinanzi una
Olivetti regolarmente funzionante. Inevitabilmente, io ascoltavo. Parlava di un
omicidio avvenuto a Pianura, quartiere napoletano. Pianura? Troppo banale,
troppo vero. Cominciò l’articolo scrivendo: «Pianura, che, ironia dei nomi e
della sorte, non ha nulla di pianeggiante». Aveva preso la collina dei
Camaldoli e l’aveva spostata, mettendoci in cima Pianura. Lo sapeva lui, lo
sapevo io, napoletano di Torre del Greco come lui. E la cosa più incredibile è
che la nuova geografia non faceva una grinza, affascinava lui e anche me.
Faceva fantasticare una Pianura in montagna o collina, aspra, cattiva come
quell’omicidio. Manco si trattasse dell’Everest. Era fatto così, così scriveva.
Credo che
gli articoli di Nino Longobardi, quelli migliori, quelli indimenticabili, siano
tutti nati pensando ad altro, cambiando la geografia. Reinterpretando. Come i
suoi libri. Come quel Diario di un ex fumatore scritto da chi non aveva mai
smesso di fumare, e forse neppure ci aveva mai pensato. Come la sua inchiesta
sul banditismo sardo, passata alla storia del giornalismo. «Stavo qua sopra.
Tutto il tempo in camera, in albergo a scrivere», mi disse quel giorno al Grand
Hotel. Disse anche il numero della camera. Aggiunse: «Il vero banditismo è a Roma.
Per vederlo e raccontarlo non c’è bisogno di andare in Sardegna».
Vero? Falso? Probabilmente falso, ma vallo a
sapere con certezza. Nino Longobardi giocava con le parole, le metafore, la
realtà. È stato un giocoliere del giornalismo e della vita. Alcune volte, un
trapezista. Camminava sul filo, sapendo che, se fosse caduto, ed è caduto,
anche lui è caduto, ad ammortizzare il colpo non ci sarebbe stata alcuna rete.
Un bel botto e tante ammaccature. Ma si rialzava, sempre con un sorriso, che
era uno sberleffo, napoletano sberleffo alla cattiva sorte.
«Nino, – disse un giorno Stefano Delli Colli –
non è possibile, è insopportabile». Eravamo in tre, quella mattina in
redazione, via Parigi 11, quotidiano Vita, con i locali che ospitavano anche il
Fiorino, giornale economico. Locali piccoli, giornalisti pochi, tanto lavoro.
Nino era la “firma”, la punta di diamante, il grande giornalista che da poco
aveva lasciato la portaerei Messaggero per salire sulla fregata Vita. «Ci stai
appestando, – disse Stefano – in redazione non si fuma». Si alzò e spalancò la
finestra. Nino lo guardò, non si scompose. E continuando a fumare disse, con
quel sorriso lì, quello sberleffo: «Questo è il sintomo della mia decadenza,
dieci anni fa nessuno si sarebbe potuto rivolgere a me così». Spense la
sigaretta e ne accese un’altra: “North Pole”, sigarette alla menta. Uno dei due
compiti che mi aveva personalmente affidato, all’epoca ero praticante a Vita,
era di comprargli quelle “North Pole” quando scendevo al bar. Due pacchetti.
Glieli ho comprati quattro o cinque volte. Alla sesta, non avendo mai ricevuto
un soldo per gli acquisti, mi inventai che la tabaccheria non aveva le “North
Pole”: aveva deciso che non le avrebbe mai più vendute perché a comprarle era
solo il dottor Longobardi, e allora non conveniva. L’altro compito era
leggermente più giornalistico: raccogliere, quando la mattina lui non veniva in
redazione, il suo “Contromano”, il corsivetto per la prima pagina stile
“Controcorrente” di Montanelli (secondo me superiore al Controcorrente di
Montanelli) o il corsivo di Fortebraccio sull’Unità. Ne ricordo uno. Vincenzo
Paparelli, 33 anni, tifoso della Lazio, era morto colpito da un razzo. Stadio
Olimpico, razzo sparato dalla curva opposta. La partita, Roma-Lazio, era finita
in pareggio. Il lunedì Longobardi dettò: «Roma Lazio: X. Una croce al merito di
Paparelli». Quel giorno avrei voluto comprargli le “North Pole”, con i soldi
miei. Ma non era in redazione.
Stava
poco in redazione, Nino Longobardi. Quando c’era, era uno spettacolo:
commentava i giornali a voce alta. Una personalissima rassegna stampa. La
redazione era il suo palcoscenico. A volte anche il suo camerino. Quando andò
via e facemmo pulizia (come avviene con il caro estinto, lui va all’altro mondo
e i superstiti si spartiscono le sue cose), nel suo cassetto trovammo un paio
di calzini, neri. Dopo molto argomentare, giungemmo alla conclusione che in una
giornata di pioggia doveva esserseli tolti, abbandonandoli, bagnati, nel
cassetto, e tornandosene a casa senza calzini. O forse no. Forse aveva spedito
l’immancabile tassista, lui viveva sempre con un tassista al seguito, a
comprargliene un altro paio.
«I tassisti – mi disse una volta – dovrebbero
farmi un monumento: “A Nino Longobardi, l’uomo che odiava le auto e rese ricchi
i tassisti”». «E la data della morte?», gli chiesi io per sfotterlo. Rispose:
«Mettici: età contemporanea. E aggiungi: la lapide è donata dai tassisti, me lo
devono». I tassisti romani, per lui, non erano solo autisti: erano al suo
servizio. Li spediva a fare le spese, o così diceva. Si faceva accompagnare dal
barbiere e loro attendevano fuori (col tassametro in funzione, naturalmente).
Così al ristorante, dall’editore, in redazione. A volte si dimenticava
addirittura che erano lì ad attenderlo. Forse ad attenderlo, perché in tanti
ben presto capirono (capirono che il lavoro c’era e i soldi non sempre
arrivavano) e quando ricevevano la telefonata dai suoi posti (la sua redazione,
la sua casa, il suo ristorante) si rendevano uccelli di bosco. «Bosco metropolitano»,
avrebbe scritto Nino, antenne al posto degli alberi, fili elettrici e non
liane. E pure i tassisti avrebbero letto e perdonato. Come lo hanno perdonato i
suoi amici, i conoscenti. E i suoi allievi, molti allievi.
Vi
sembrerà strano che uno scriva perché gliel’ha chiesto l’autore di questo
libro, che sappia che lo scritto sarà inserito nel libro per i vent’anni dalla
morte di Nino Longobardi, e che dica che l’autore ha commesso un errore. No,
non è vero che Nino Longobardi non ebbe allievi: ne ebbe tanti. Ma era scomodo,
controcorrente. E allora si apprendeva da lui, si rubava dai suoi articoli. E
si diceva di non conoscerlo. Tutti così. Io ho sempre detto, e scritto, che
Nino Longobardi è stato uno dei miei maestri: non ho mai pensato che l’essere
scomodo fosse sinonimo di essere stupido o incapace. Lo dissi anche a lui,
quella volta al Grand Hotel, i giornali per terra, la poltrona enorme. Enormi
le sale, alti i soffitti, imponenti gli arredi. Lì dentro Nino sembrava un re
seduto su un trono. Un re un po’ strano, visto che indossava una tuta da sci.
Non poteva accontentarsi di essere un re come tutti gli altri.
Lui
doveva stupire, recitare, inventare, sempre dicendo cose vere, verissime.
«Ricordati, – mi disse quel giorno congedandomi – sei giovane, devi
ricordartelo: quelli che parlano di giornalismo libero, pluralità delle testate
dicono sciocchezze. Prima di tutto deve essere libera la testa, come la mia
testa. Se vuoi, puoi farne il titolo della tua intervista». E alzò il braccio,
la mano si avvicinò alla testa. Ma non la raggiunse, non poteva raggiungerla e
toccarla. Sopra c’era la corona, che brillava. E brilla, la corona di Nino,
eccome se brilla, anche oggi, a vent’anni dalla sua morte.
Mattias Mainiero