
Sarà «ingrillato in chiave antipolitica» - come ha anticipato qualche giorno fa Dagospia, il sito di quel segugio postmoderno di Roberto D’Agostino, segnalando l’esistenza di un brano dal titolo decisamente polemico, Comunisti al sole – o continuerà sulla via del pop sentimentale degli ultimi anni?
 L’ormai imminente ritorno sulla scena discografica di Antonello Venditti è avvolto dal mistero, sapientemente alimentato da quel gran… sornione del cantautore romano.
L’ormai imminente ritorno sulla scena discografica di Antonello Venditti è avvolto dal mistero, sapientemente alimentato da quel gran… sornione del cantautore romano.Dopodomani, finalmente, potremo ascoltarlo, sapremo e riferiremo. Dalla pelle al cuore, il brano “civetta” che dà il titolo al nuovo atteso album di inediti – l’ultimo, Che fantastica storia è la vita, è di quattro anni fa – sarà in programmazione radiofonica, e disponibile in formato digitale su tutte le piattaforme web e mobile italiane, da venerdì 12 ottobre. Per il cd, ricco di nove nuovi pezzi, bisognerà aspettare poco più di un mese, il 16 novembre. Ed è già – neanche a dirlo – un successo annunciato.
 Notte prima degli esami. Titolo che Fausto Brizzi gli ha soffiato per farne una commedia simpatica ma decisamente meno evocativa della canzone, chiamando Claudia – per giunta, scostumato! – la protagonista del film. Altrettanto aveva fatto Gabriele Muccino per la sua pellicola d’esordio, Ricordati di me (altro titolo vendittiano presente nell’album In questo mondo di ladri del ‘88). E cosa dire di Maurizio Costanzo che, per battezzare uno dei programmi-contenitore più trash nella storia della televisione, ha preso da anni a prestito Buona Domenica, altra splendida ballata del ’89 di Venditti? Alla fine il nostro è sbottato, scendendo sul piede di guerra e reclamando i diritti d’autore. «Mi sono stufato di vedere usati i titoli delle mie canzoni! E’ paradossale – ha osservato – che se ora volessi scrivere un libro intitolato Notte prima degli esami non potrei. Ricordati di me passi, ma neanche tanto, perché hanno costretto il cantautore Pacifico a
Notte prima degli esami. Titolo che Fausto Brizzi gli ha soffiato per farne una commedia simpatica ma decisamente meno evocativa della canzone, chiamando Claudia – per giunta, scostumato! – la protagonista del film. Altrettanto aveva fatto Gabriele Muccino per la sua pellicola d’esordio, Ricordati di me (altro titolo vendittiano presente nell’album In questo mondo di ladri del ‘88). E cosa dire di Maurizio Costanzo che, per battezzare uno dei programmi-contenitore più trash nella storia della televisione, ha preso da anni a prestito Buona Domenica, altra splendida ballata del ’89 di Venditti? Alla fine il nostro è sbottato, scendendo sul piede di guerra e reclamando i diritti d’autore. «Mi sono stufato di vedere usati i titoli delle mie canzoni! E’ paradossale – ha osservato – che se ora volessi scrivere un libro intitolato Notte prima degli esami non potrei. Ricordati di me passi, ma neanche tanto, perché hanno costretto il cantautore Pacifico a  scrivere una canzone con quel titolo». Sì, perché Antonello Venditti è un viscerale, di quelli che dicono quello che pensano. Diciamolo pure: non è un simpaticone, il che – in un’epoca in cui tutti hanno l’ambizione di piacere a tutti – è decisamente un merito. Dopo il debutto con De Gregori, la separazione. E, salvo momentanei riavvicinamenti, la distanza. Persino nei giudizi sul nascente partito democratico e sul comune amico Water Veltroni. Per De Gregori, che gli preferisce Rosy Bindi, «quel che dice Veltroni spesso è difficile da afferrare, da decifrare, dice tutto e il contrario di tutto. Mostra una grande ansia di piacere, di essere appetibile a destra e a manca». Per Venditti, al contrario, «è semplicemente educato, sa ascoltare e preferisce proporre che distruggere».
scrivere una canzone con quel titolo». Sì, perché Antonello Venditti è un viscerale, di quelli che dicono quello che pensano. Diciamolo pure: non è un simpaticone, il che – in un’epoca in cui tutti hanno l’ambizione di piacere a tutti – è decisamente un merito. Dopo il debutto con De Gregori, la separazione. E, salvo momentanei riavvicinamenti, la distanza. Persino nei giudizi sul nascente partito democratico e sul comune amico Water Veltroni. Per De Gregori, che gli preferisce Rosy Bindi, «quel che dice Veltroni spesso è difficile da afferrare, da decifrare, dice tutto e il contrario di tutto. Mostra una grande ansia di piacere, di essere appetibile a destra e a manca». Per Venditti, al contrario, «è semplicemente educato, sa ascoltare e preferisce proporre che distruggere».  piccolo Budda. Quello che in futuro poteva trasformare il Pci a nostra somiglianza». Evidentemente, ritennero, non era il momento e l’impresa decisamente velleitaria. Veltroni il partito democratico non l’avrà fatto da solo – come gli aveva suggerito Venditti – ma in qualche modo, bello e confezionato, arriva il 14 prossimo venturo, magari proprio sulle note fresche di Venditti che, di politica, non s’è più interessato. Ed è stato un bene. Per la politica, ma soprattutto per lui. E – diciamocelo – per noi. Perché in questi trent’anni ci ha regalato canzoni bellissime. Perché nella colonna sonora della nostra vita – e non parlo solo di “noi” quarantenni – ha fatto e fa ancora la parte del leone. Conosciamo a memoria i testi, le mille storie di piccoli eroismi quotidiani, di esami e solitudini, di amicizia e amori disperati in anni – quali i ’70 – «in cui era difficile parlare d’amore. Per noi cantautori la parola d’ordine era impegno». Ed è come se avessimo conosciuto anche le tante figure femminili che affollano le sue canzoni. La Claudia plagiata da Muccino – come
piccolo Budda. Quello che in futuro poteva trasformare il Pci a nostra somiglianza». Evidentemente, ritennero, non era il momento e l’impresa decisamente velleitaria. Veltroni il partito democratico non l’avrà fatto da solo – come gli aveva suggerito Venditti – ma in qualche modo, bello e confezionato, arriva il 14 prossimo venturo, magari proprio sulle note fresche di Venditti che, di politica, non s’è più interessato. Ed è stato un bene. Per la politica, ma soprattutto per lui. E – diciamocelo – per noi. Perché in questi trent’anni ci ha regalato canzoni bellissime. Perché nella colonna sonora della nostra vita – e non parlo solo di “noi” quarantenni – ha fatto e fa ancora la parte del leone. Conosciamo a memoria i testi, le mille storie di piccoli eroismi quotidiani, di esami e solitudini, di amicizia e amori disperati in anni – quali i ’70 – «in cui era difficile parlare d’amore. Per noi cantautori la parola d’ordine era impegno». Ed è come se avessimo conosciuto anche le tante figure femminili che affollano le sue canzoni. La Claudia plagiata da Muccino – come  fargliene una colpa, è cresciuto anche lui con Venditti che gli suonava nella testa – la tossica Lilly con «quattro buchi nella pelle», Marta divisa «tra il salario e la pagella», la giovane Sara in dolce attesa da non entrare più nel banco di scuola, la volitiva Giulia, la timida Paola, «Valle Giulia ancora brilla la luna e Paola prende la mia mano caduta per sbaglio sui nostri vent’anni tesi come coltelli». E Cinzia, che «cantava le sue canzoni e si scriveva i testi sul diario per sentirli veri». E ancora Marina, ex sessantottina che «se n’è andata e oggi insegna in una scuola». Rispetto agli anni della contestazione, quando manifestò con gli studenti a Valle Giulia contro gli "sbirri", Venditti non si sente cambiato e rivendica la sua coerenza di cattolico "de sinistra": «Ho vissuto in maniera laica, anche se ho portato con me l’educazione cristiana datami da mia madre, cattolica praticante. La conferma viene anche dal mio linguaggio che non è tipico della cultura di sinistra». Del resto, con una madre professoressa, un padre ex combattente, liceo di destra per antonomasia - "la giovane destra cantava / eja, eja, alalà, fa la sua canzone Giulio Cesare - dove insegnava la madre.
fargliene una colpa, è cresciuto anche lui con Venditti che gli suonava nella testa – la tossica Lilly con «quattro buchi nella pelle», Marta divisa «tra il salario e la pagella», la giovane Sara in dolce attesa da non entrare più nel banco di scuola, la volitiva Giulia, la timida Paola, «Valle Giulia ancora brilla la luna e Paola prende la mia mano caduta per sbaglio sui nostri vent’anni tesi come coltelli». E Cinzia, che «cantava le sue canzoni e si scriveva i testi sul diario per sentirli veri». E ancora Marina, ex sessantottina che «se n’è andata e oggi insegna in una scuola». Rispetto agli anni della contestazione, quando manifestò con gli studenti a Valle Giulia contro gli "sbirri", Venditti non si sente cambiato e rivendica la sua coerenza di cattolico "de sinistra": «Ho vissuto in maniera laica, anche se ho portato con me l’educazione cristiana datami da mia madre, cattolica praticante. La conferma viene anche dal mio linguaggio che non è tipico della cultura di sinistra». Del resto, con una madre professoressa, un padre ex combattente, liceo di destra per antonomasia - "la giovane destra cantava / eja, eja, alalà, fa la sua canzone Giulio Cesare - dove insegnava la madre. 
Cosa rimane di quelle utopie, si chiede Venditti. «Solamente unità e amore per noi». Consapevolezza che affiora già nel ’78 in Sotto il segno dei pesci: «Ti ricordi quella strada, eravamo io e te, e la gente che correva e gridava insieme a noi, tutto quel che voglio pensavo, è solamente amore…». Salvo concludere, con un fondo di amarezza, in Noi nell’album Benvenuti in paradiso del ’91: «Noi sotto il segno dei pesci noi… noi che sognavamo a occhi aperti, adesso siamo i perdenti noi». Canzoni nelle quali può riconoscersi chiunque abbia partecipato a un corteo, a una manifestazione di qualsiasi segno, a prescindere dalle diverse scelte di campo. Per questo il cantautore romano piace da sempre anche a destra e, come nei live al Circo Massimo di Roma, riempie gli stadi unificandoci tutti nel nome dell’immaginario condiviso, quello dove – per intenderci – «Nietzsche e Marx si davano la mano».
Nel nuovo album c’è naturalmente l’amata Roma – «il set della mia anima» – con una canzone bella e struggente, Piove su Roma, «una suite sulla città e per la città», ma anche il tema della disill
 usione politica tornerà a trovare spazio. L’ammissione è arrivata, qualche giorno fa, proprio da Venditti. Uno dei temi trattati in questo cd «passionale, emozionante, tra laico e cristino», infatti, sarà quello del tradimento. «Si parla d’amore, di vita, di politica e dei tradimenti che attraversano la nostra esistenza» Il riferimento, esplicito, è ai campioni traditi dal successo, abbandonati da quel pubblico che prima ne fa delle icone e poi, quando la fortuna cambia direzione, abbandona al proprio destino. Venditti cita Marco Pantani e Luigi Tenco ma l’ispirazione principale rimane soprattutto il suicidio di Agostino Di Bartolomei – «un caro amico, pensavo a lui quando mi sono messo a comporre» – che si tolse la vita il 30 maggio del ’94, esattamente dieci anni dopo una delle pagine più tristi della storia calcistica giallorossa: la sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool. Ma tradimento è anche quello politico. «La gente vuole sentirsi seriamente rappresentata da persone che ci mettono passione. Ecco perché spesso ci troviamo a rispettare di più i nostri avversari. Se anche non ne condividiamo le idee si può apprezzare la serietà e la buona fede. D’altronde molti laziali da sempre mi sussurrano “peccato che sei romanista!”». Chi scrive, che romanista non è, conferma. Perché Venditti si fa amare, comunque.
usione politica tornerà a trovare spazio. L’ammissione è arrivata, qualche giorno fa, proprio da Venditti. Uno dei temi trattati in questo cd «passionale, emozionante, tra laico e cristino», infatti, sarà quello del tradimento. «Si parla d’amore, di vita, di politica e dei tradimenti che attraversano la nostra esistenza» Il riferimento, esplicito, è ai campioni traditi dal successo, abbandonati da quel pubblico che prima ne fa delle icone e poi, quando la fortuna cambia direzione, abbandona al proprio destino. Venditti cita Marco Pantani e Luigi Tenco ma l’ispirazione principale rimane soprattutto il suicidio di Agostino Di Bartolomei – «un caro amico, pensavo a lui quando mi sono messo a comporre» – che si tolse la vita il 30 maggio del ’94, esattamente dieci anni dopo una delle pagine più tristi della storia calcistica giallorossa: la sconfitta nella finale di Coppa dei Campioni con il Liverpool. Ma tradimento è anche quello politico. «La gente vuole sentirsi seriamente rappresentata da persone che ci mettono passione. Ecco perché spesso ci troviamo a rispettare di più i nostri avversari. Se anche non ne condividiamo le idee si può apprezzare la serietà e la buona fede. D’altronde molti laziali da sempre mi sussurrano “peccato che sei romanista!”». Chi scrive, che romanista non è, conferma. Perché Venditti si fa amare, comunque. 

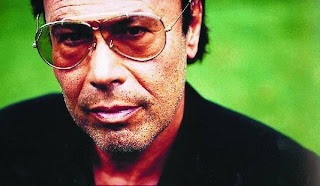


 ano» – per sua confessione – Diario di un millennio che fugge (Theoria ’86). E invece sì, Il Corriere della Sera ha fatto il suo nome per quelle liste. Nessuna omonimia, è proprio lui: «Marco Lodoli, scrittore». E in quella compagnia... Passi per Lidia Ravera e i suoi "porci con le ali", volino pure dove meglio credono. Passi per il matematico Piergiorgio Odifreddi che – fedele al proprio cognome – non molto tempo fa ha sentenziato che la parola “cretino” deriva etimologicamente dalla parola “cristiano”. L’ultima fatica “letteraria” di quest’ultimo è (sic!) Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici). I libri di Lodoli, però, sono altra cosa: sentieri impervi e mai scontati, «percorsi danteschi dal fango alla luce» nei quali non c’è traccia di valori prêt-à-porter in saldi di fine stagione (ideologica), ma so
ano» – per sua confessione – Diario di un millennio che fugge (Theoria ’86). E invece sì, Il Corriere della Sera ha fatto il suo nome per quelle liste. Nessuna omonimia, è proprio lui: «Marco Lodoli, scrittore». E in quella compagnia... Passi per Lidia Ravera e i suoi "porci con le ali", volino pure dove meglio credono. Passi per il matematico Piergiorgio Odifreddi che – fedele al proprio cognome – non molto tempo fa ha sentenziato che la parola “cretino” deriva etimologicamente dalla parola “cristiano”. L’ultima fatica “letteraria” di quest’ultimo è (sic!) Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici). I libri di Lodoli, però, sono altra cosa: sentieri impervi e mai scontati, «percorsi danteschi dal fango alla luce» nei quali non c’è traccia di valori prêt-à-porter in saldi di fine stagione (ideologica), ma so




 ivare a quella finestra che affaccia sul significato ultimo delle cose». L’intelligenza – osserva – separa, giudica, contrappone: «La letteratura abbraccia, perdona e coglie l’unità segreta che sta dietro l’apparente frantumazione del reale». E certo non è facile trasmettere ai giovani l’etica del sacrifico quando «il mondo intero afferma il contrario e in televisione e sui manifesti pubblicitari tutti ridono felici e abbronzati e nessuno è mai sudato». Del resto, la modernità ci aveva promesso «una società nella quale non avremmo più sofferto, il sogno di una rosa senza spine». Senza badare agli effetti collaterali: «Ogni nobile illusione viene immediatamente scartata perché prevede una fatica che non si desidera più compiere». I ragazzi, specialmente quelli delle periferie (Lodoli insegna in un istituto professionale), non sono più disposti a impegnarsi, si ritirano da ogni confronto, anche da quello più importante: con la loro vita e i loro sogni. Rinunciano a «essere gli artigiani della propria e
ivare a quella finestra che affaccia sul significato ultimo delle cose». L’intelligenza – osserva – separa, giudica, contrappone: «La letteratura abbraccia, perdona e coglie l’unità segreta che sta dietro l’apparente frantumazione del reale». E certo non è facile trasmettere ai giovani l’etica del sacrifico quando «il mondo intero afferma il contrario e in televisione e sui manifesti pubblicitari tutti ridono felici e abbronzati e nessuno è mai sudato». Del resto, la modernità ci aveva promesso «una società nella quale non avremmo più sofferto, il sogno di una rosa senza spine». Senza badare agli effetti collaterali: «Ogni nobile illusione viene immediatamente scartata perché prevede una fatica che non si desidera più compiere». I ragazzi, specialmente quelli delle periferie (Lodoli insegna in un istituto professionale), non sono più disposti a impegnarsi, si ritirano da ogni confronto, anche da quello più importante: con la loro vita e i loro sogni. Rinunciano a «essere gli artigiani della propria e




 dal Secolo d'Italia di mercoledì 12 settembre 2007
dal Secolo d'Italia di mercoledì 12 settembre 2007




 la necessità di trasmettere uno stato positivo, creativo. L’intera l’opera di Haring si fonda proprio su questo assunto: stimolando l’immaginazione si possono influenzare positivamente gli uomini e cambiare il mondo in meglio, a partire dai giovani. Non è un caso che l’arte di Haring sia in gran parte dedicata proprio ai bambini: «I bebè rappresentano la possibilità del futuro, di come potremmo essere perfetti. Non c’è mai nulla di negativo in un neonato, nulla. La ragione per la quale il bebè è diventato il mio logo o la mia firma è che si tratta dell’esperienza più pura e positiva dell’esistenza umana». Nei suoi disegni, sospesi tra suggestioni primordiali e futuristiche, affronta l’attualità: il nucleare, l’aparthied, l’orrore dell’Aids, la malattia che scriverà la parola fine ad una vita consumata all’insegna della velocità. Dopo il liceo frequenta l’Ivy School of Professional Art di Pittsburgh e la scuola di Commercial Art, ma il richiamo, prima della strada – gira il paese in autostop sull’onda della contestazione giovanile – e poi di New York, è troppo forte. Nei primi anni Otta
la necessità di trasmettere uno stato positivo, creativo. L’intera l’opera di Haring si fonda proprio su questo assunto: stimolando l’immaginazione si possono influenzare positivamente gli uomini e cambiare il mondo in meglio, a partire dai giovani. Non è un caso che l’arte di Haring sia in gran parte dedicata proprio ai bambini: «I bebè rappresentano la possibilità del futuro, di come potremmo essere perfetti. Non c’è mai nulla di negativo in un neonato, nulla. La ragione per la quale il bebè è diventato il mio logo o la mia firma è che si tratta dell’esperienza più pura e positiva dell’esistenza umana». Nei suoi disegni, sospesi tra suggestioni primordiali e futuristiche, affronta l’attualità: il nucleare, l’aparthied, l’orrore dell’Aids, la malattia che scriverà la parola fine ad una vita consumata all’insegna della velocità. Dopo il liceo frequenta l’Ivy School of Professional Art di Pittsburgh e la scuola di Commercial Art, ma il richiamo, prima della strada – gira il paese in autostop sull’onda della contestazione giovanile – e poi di New York, è troppo forte. Nei primi anni Otta


 i schizofrenici, oscillante tra permissivismo e repressione. Così, dopo aver previsto, in quel di Firenze, la “geniale” trovata dell’arresto per i lavavetri, dopo l’uscita del film si prevederanno misure più severe anche per i writers. Del resto, già nel 2001, persino un graffito di Haring dalle dimensione di 6 x 2 metri realizzato nella metropolitana di Roma (linea A, tratto Flaminio-Lepanto, sulle pareti trasparenti del ponte sul Tevere), è stato cancellato senza complimenti. Se in Francia, all’università di Saint Denis, Cultura Pop e graffiti sono diventati materia d’esame, qualche anno fa l’allora ministro ai Beni Culturali Alberto Ronchey ingaggiò una sua personale battaglia presentando un apposito disegno di legge contro quella che riteneva una “forma di vandalismo”. La soluzione attualmente allo studio sembrerebbe essere quella – oltre alla solita campagna di sensibilizzazione – di limitare l’illegalità destinando spazi autorizzati ai writer, con tanto di albo profession
i schizofrenici, oscillante tra permissivismo e repressione. Così, dopo aver previsto, in quel di Firenze, la “geniale” trovata dell’arresto per i lavavetri, dopo l’uscita del film si prevederanno misure più severe anche per i writers. Del resto, già nel 2001, persino un graffito di Haring dalle dimensione di 6 x 2 metri realizzato nella metropolitana di Roma (linea A, tratto Flaminio-Lepanto, sulle pareti trasparenti del ponte sul Tevere), è stato cancellato senza complimenti. Se in Francia, all’università di Saint Denis, Cultura Pop e graffiti sono diventati materia d’esame, qualche anno fa l’allora ministro ai Beni Culturali Alberto Ronchey ingaggiò una sua personale battaglia presentando un apposito disegno di legge contro quella che riteneva una “forma di vandalismo”. La soluzione attualmente allo studio sembrerebbe essere quella – oltre alla solita campagna di sensibilizzazione – di limitare l’illegalità destinando spazi autorizzati ai writer, con tanto di albo profession







