Articolo di Federico Zamboni
Dal Secolo d'Italia, edizione domenicale del 21 febbraio 2010

Non basta evitare le autostrade, per arrivare in posti insoliti e rivelatori che valga davvero la pena di raggiungere. E non basta tenersi alla larga dalla massa, per trasformare l'isolamento nel presupposto di un'ascesa interiore. Rimescolare le carte è il minimo, se si vuole iniziare una nuova partita. Ma per cominciare un altro tipo di gioco, che vada al di là del passatempo, o del brivido dell'azzardo, quello che va cambiato è il mazzo: tra le carte francesi e i tarocchi non cambia soltanto la grafica. Non cambia soltanto la forma.
per trasformare l'isolamento nel presupposto di un'ascesa interiore. Rimescolare le carte è il minimo, se si vuole iniziare una nuova partita. Ma per cominciare un altro tipo di gioco, che vada al di là del passatempo, o del brivido dell'azzardo, quello che va cambiato è il mazzo: tra le carte francesi e i tarocchi non cambia soltanto la grafica. Non cambia soltanto la forma.
Peter Gabriel, come accade spesso ai migliori, ha viaggiato moltissimo sulle strade della propria arte, assai più di quanto si possa pensare se ci si limita a contare i suoi pochi album da solista, appena sette sull'arco dei 35 anni ormai trascorsi da quando abbandonò i Genesis all'indomani di The Lamb Lies Down on Broadway.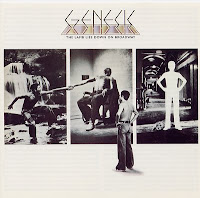 Come accade quasi sempre, il tesoro della conoscenza è stato pagato con la moneta, pressoché insostituibile, della capacità di meravigliarsi. Quel sacchetto di tintinnanti zecchini che ognuno di noi riceve alla nascita, insieme ai tanti altri doni che si perderanno chissà dove ancora prima di aver capito cos'erano, e quale ottimo uso se ne sarebbe potuto fare, si è fatalmente svuotato. Del tutto, o quasi. Peter Gabriel, che ad appena 21 anni era già capace di un incantesimo splendido e raggelante come The Musical Box, non si è perso d'animo. In prossimità dei sessanta, che ha compiuto il 13 febbraio, si è rimesso in movimento come un gentiluomo saggio che dopo molto tempo esce a piedi dalla sua immensa tenuta e si spinge in paese, con l'esplicito proposito di mischiarsi un po' con quelli che di solito non frequenta. Ai domestici ha detto di non aspettarlo: non sa quando tornerà. Al maggiordomo, che gli ricordava di rifornirsi di denaro (i prezzi sono molto aumentati, giù al villaggio), ha risposto che ci aveva già pensato. Ma lo ha fatto solo per non allarmarlo, essendo risaputo che i maggiordomi prediligono l'ordine e aborrono le rivelazioni improvvise. La verità se l'è tenuta dentro. La verità è che non vuole comprare nulla. Quello che riceverà, se è destino che così debba essere, lo riceverà in regalo. Il potere del dono. La magia del dono.
Come accade quasi sempre, il tesoro della conoscenza è stato pagato con la moneta, pressoché insostituibile, della capacità di meravigliarsi. Quel sacchetto di tintinnanti zecchini che ognuno di noi riceve alla nascita, insieme ai tanti altri doni che si perderanno chissà dove ancora prima di aver capito cos'erano, e quale ottimo uso se ne sarebbe potuto fare, si è fatalmente svuotato. Del tutto, o quasi. Peter Gabriel, che ad appena 21 anni era già capace di un incantesimo splendido e raggelante come The Musical Box, non si è perso d'animo. In prossimità dei sessanta, che ha compiuto il 13 febbraio, si è rimesso in movimento come un gentiluomo saggio che dopo molto tempo esce a piedi dalla sua immensa tenuta e si spinge in paese, con l'esplicito proposito di mischiarsi un po' con quelli che di solito non frequenta. Ai domestici ha detto di non aspettarlo: non sa quando tornerà. Al maggiordomo, che gli ricordava di rifornirsi di denaro (i prezzi sono molto aumentati, giù al villaggio), ha risposto che ci aveva già pensato. Ma lo ha fatto solo per non allarmarlo, essendo risaputo che i maggiordomi prediligono l'ordine e aborrono le rivelazioni improvvise. La verità se l'è tenuta dentro. La verità è che non vuole comprare nulla. Quello che riceverà, se è destino che così debba essere, lo riceverà in regalo. Il potere del dono. La magia del dono.
Scratch My Back, tecnicamente parlando un album di cover, è il frutto di questa uscita dai confini dell'abituale coincidenza, in Gabriel, tra l'interprete e l'autore. P eter non voleva mettersi alla prova. Voleva essere sorpreso. Riversare la sua voce in un contesto preesistente e osservare la reazione che si produceva in quella serie di alambicchi affascinanti e ormai stabilizzati, aggiungendovi le gocce di un composto di tutt'altra origine. Un alchimista in trasferta, che si reca a rendere omaggio a dei colleghi talentuosi che lavorano su formule completamente diverse dalle sue - già celebri come Paul Simon e Lou Reed, come Neil Young e i Radiohead, o meno famosi come Elbow e Bon Iver, come Arcade Fire e Regina Spektor - ma solo a condizione che la sua visita sia gradita, e che ci sia un impegno a ricambiarla. Dietro Scratch My Back, infatti, c'è un patto già sottoscritto: a ogni rielaborazione contenuta nel disco seguirà, nei prossimi mesi, una replica a posizioni rovesciate, che confluirà in una raccolta "gemella" intitolata I'll Scratch Yours. Apparentemente uno scambio di cortesie. In realtà un esperimento.
eter non voleva mettersi alla prova. Voleva essere sorpreso. Riversare la sua voce in un contesto preesistente e osservare la reazione che si produceva in quella serie di alambicchi affascinanti e ormai stabilizzati, aggiungendovi le gocce di un composto di tutt'altra origine. Un alchimista in trasferta, che si reca a rendere omaggio a dei colleghi talentuosi che lavorano su formule completamente diverse dalle sue - già celebri come Paul Simon e Lou Reed, come Neil Young e i Radiohead, o meno famosi come Elbow e Bon Iver, come Arcade Fire e Regina Spektor - ma solo a condizione che la sua visita sia gradita, e che ci sia un impegno a ricambiarla. Dietro Scratch My Back, infatti, c'è un patto già sottoscritto: a ogni rielaborazione contenuta nel disco seguirà, nei prossimi mesi, una replica a posizioni rovesciate, che confluirà in una raccolta "gemella" intitolata I'll Scratch Yours. Apparentemente uno scambio di cortesie. In realtà un esperimento.
«Ho esplorato alcune differenti idee di arrangiamento», si legge nelle note di copertina. E la parol a chiave è proprio quella: esplorato. La musica che viene incisa non è mai il solo punto di arrivo al quale si poteva pervenire muovendo da certe premesse: nella sua forma più alta ogni arrangiamento è una riscrittura, una reinvenzione che non si limita a clonare l'originale, ma che lo feconda in vista di una nuova nascita. Di un nuovo destino. Quello che credevamo un figlio unico ha almeno un fratello, e forse più di uno. Si assomigliano, ma non troppo. Si danno ragione d'istinto. Si contraddicono senza malanimo.
a chiave è proprio quella: esplorato. La musica che viene incisa non è mai il solo punto di arrivo al quale si poteva pervenire muovendo da certe premesse: nella sua forma più alta ogni arrangiamento è una riscrittura, una reinvenzione che non si limita a clonare l'originale, ma che lo feconda in vista di una nuova nascita. Di un nuovo destino. Quello che credevamo un figlio unico ha almeno un fratello, e forse più di uno. Si assomigliano, ma non troppo. Si danno ragione d'istinto. Si contraddicono senza malanimo.
Alla fine, tra le tante possibili, la scelta di Peter Gabriel è stata drastica: niente chitarre e niente batteria. Via i capisaldi del pop, tanto per essere più sicuri (un po' più sicuri) di non lasciarsi tentare dalle soluzioni abituali. Sprigionare il ritmo appoggiandosi ai tamburi è troppo facile. Risultare accattivanti usando i soliti strumenti è quasi un sotterfugio. Il grande pubblico confonde la bellezza con la familiarità. Gli artisti, quelli veri, dovrebbero ricordargli che la familiarità è il riflesso di un'abitudine. Quasi sempre casuale. Spesso cattiva.
Niente chitarre e niente batteria. Al loro posto, un'orchestra. Fitta di archi e di ottoni. E guidata dal pianoforte. Quell'orchestra che nell'immaginario collettivo è l'università de lla musica; un concentrato di dignità; un crisma di autorevolezza. La migliore ambientazione possibile di quel racconto sonoro che è una grande melodia. Ma anche un equivoco, se non si sta attenti. Un'ambizione malriposta, per quei brani che siano nati, invece, per un'esecuzione semplificata. E di solito, infatti, quando il pop e il rock cedono alla tentazione di autocelebrarsi ergendosi in chiave sinfonica ne escono travolti e sbugiardati, come poveracci che abbiano rubato degli abiti di lusso e che ora, fatalmente, li indossino senza alcuna naturalezza. Con una goffaggine, o con un eccesso di compiacimento, che svelano il furto meglio di qualsiasi confessione.
lla musica; un concentrato di dignità; un crisma di autorevolezza. La migliore ambientazione possibile di quel racconto sonoro che è una grande melodia. Ma anche un equivoco, se non si sta attenti. Un'ambizione malriposta, per quei brani che siano nati, invece, per un'esecuzione semplificata. E di solito, infatti, quando il pop e il rock cedono alla tentazione di autocelebrarsi ergendosi in chiave sinfonica ne escono travolti e sbugiardati, come poveracci che abbiano rubato degli abiti di lusso e che ora, fatalmente, li indossino senza alcuna naturalezza. Con una goffaggine, o con un eccesso di compiacimento, che svelano il furto meglio di qualsiasi confessione.
Peter Gabriel schiva la trappola. Non ha nessuna intenzione di sedurre con lo sfarzo. Non vuole fare leva su un singolo aspetto della costruzione che va innalzando, conscio che nell'opera d'arte ideale non c'è nulla che serva solo come prologo al colpo ad affett o. Nonostante l'orchestra - o grazie a questa specifica modalità di avvalersene - non c'è nulla di enfatico. Semmai il contrario. L'impressione che trasmette è quella di un uomo che stia cantando a occhi chiusi, totalmente assorbito dal tentativo di seguire il filo dei suoi pensieri - e delle sue emozioni.
o. Nonostante l'orchestra - o grazie a questa specifica modalità di avvalersene - non c'è nulla di enfatico. Semmai il contrario. L'impressione che trasmette è quella di un uomo che stia cantando a occhi chiusi, totalmente assorbito dal tentativo di seguire il filo dei suoi pensieri - e delle sue emozioni.
I brani come ricordi lontani che riaffiorano a poco a poco. Gli orchestrali come amici discreti che assistono a questa meditazione solitaria, e muovendosi pian piano aggiungono un altro pezzetto di legno, o un altro granello di incenso, sul braciere che arde nella penombra.
Federico Zamboni, nato a Milano nel 1958 ma cresciuto a Roma, è giornalista e conduttore radiofonico. Tra il 1979 e il 1981, con lo pseudonimo di Claudio Fossati, ha tenuto una rubrica (quasi) fissa sul quindicinale “Linea”, dedicata a quella che allora si chiamava la “musica giovanile”. Dopo aver smesso di scrivere articoli per circa 15 anni, dedicandosi a tutt’altre cose, ha ripreso a pubblicare regolarmente nel 2000 su Ideazione.com. Attualmente, tra l’altro, cura la rubrica “Ad alto volume” sull’edizione domenicale del "Secolo d’Italia" e collabora al mensile “La voce del ribelle”, la rivista diretta da Massimo Fini.
 per trasformare l'isolamento nel presupposto di un'ascesa interiore. Rimescolare le carte è il minimo, se si vuole iniziare una nuova partita. Ma per cominciare un altro tipo di gioco, che vada al di là del passatempo, o del brivido dell'azzardo, quello che va cambiato è il mazzo: tra le carte francesi e i tarocchi non cambia soltanto la grafica. Non cambia soltanto la forma.
per trasformare l'isolamento nel presupposto di un'ascesa interiore. Rimescolare le carte è il minimo, se si vuole iniziare una nuova partita. Ma per cominciare un altro tipo di gioco, che vada al di là del passatempo, o del brivido dell'azzardo, quello che va cambiato è il mazzo: tra le carte francesi e i tarocchi non cambia soltanto la grafica. Non cambia soltanto la forma.Peter Gabriel, come accade spesso ai migliori, ha viaggiato moltissimo sulle strade della propria arte, assai più di quanto si possa pensare se ci si limita a contare i suoi pochi album da solista, appena sette sull'arco dei 35 anni ormai trascorsi da quando abbandonò i Genesis all'indomani di The Lamb Lies Down on Broadway.
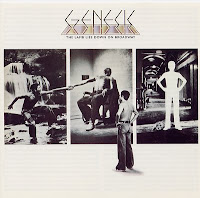 Come accade quasi sempre, il tesoro della conoscenza è stato pagato con la moneta, pressoché insostituibile, della capacità di meravigliarsi. Quel sacchetto di tintinnanti zecchini che ognuno di noi riceve alla nascita, insieme ai tanti altri doni che si perderanno chissà dove ancora prima di aver capito cos'erano, e quale ottimo uso se ne sarebbe potuto fare, si è fatalmente svuotato. Del tutto, o quasi. Peter Gabriel, che ad appena 21 anni era già capace di un incantesimo splendido e raggelante come The Musical Box, non si è perso d'animo. In prossimità dei sessanta, che ha compiuto il 13 febbraio, si è rimesso in movimento come un gentiluomo saggio che dopo molto tempo esce a piedi dalla sua immensa tenuta e si spinge in paese, con l'esplicito proposito di mischiarsi un po' con quelli che di solito non frequenta. Ai domestici ha detto di non aspettarlo: non sa quando tornerà. Al maggiordomo, che gli ricordava di rifornirsi di denaro (i prezzi sono molto aumentati, giù al villaggio), ha risposto che ci aveva già pensato. Ma lo ha fatto solo per non allarmarlo, essendo risaputo che i maggiordomi prediligono l'ordine e aborrono le rivelazioni improvvise. La verità se l'è tenuta dentro. La verità è che non vuole comprare nulla. Quello che riceverà, se è destino che così debba essere, lo riceverà in regalo. Il potere del dono. La magia del dono.
Come accade quasi sempre, il tesoro della conoscenza è stato pagato con la moneta, pressoché insostituibile, della capacità di meravigliarsi. Quel sacchetto di tintinnanti zecchini che ognuno di noi riceve alla nascita, insieme ai tanti altri doni che si perderanno chissà dove ancora prima di aver capito cos'erano, e quale ottimo uso se ne sarebbe potuto fare, si è fatalmente svuotato. Del tutto, o quasi. Peter Gabriel, che ad appena 21 anni era già capace di un incantesimo splendido e raggelante come The Musical Box, non si è perso d'animo. In prossimità dei sessanta, che ha compiuto il 13 febbraio, si è rimesso in movimento come un gentiluomo saggio che dopo molto tempo esce a piedi dalla sua immensa tenuta e si spinge in paese, con l'esplicito proposito di mischiarsi un po' con quelli che di solito non frequenta. Ai domestici ha detto di non aspettarlo: non sa quando tornerà. Al maggiordomo, che gli ricordava di rifornirsi di denaro (i prezzi sono molto aumentati, giù al villaggio), ha risposto che ci aveva già pensato. Ma lo ha fatto solo per non allarmarlo, essendo risaputo che i maggiordomi prediligono l'ordine e aborrono le rivelazioni improvvise. La verità se l'è tenuta dentro. La verità è che non vuole comprare nulla. Quello che riceverà, se è destino che così debba essere, lo riceverà in regalo. Il potere del dono. La magia del dono.Scratch My Back, tecnicamente parlando un album di cover, è il frutto di questa uscita dai confini dell'abituale coincidenza, in Gabriel, tra l'interprete e l'autore. P
 eter non voleva mettersi alla prova. Voleva essere sorpreso. Riversare la sua voce in un contesto preesistente e osservare la reazione che si produceva in quella serie di alambicchi affascinanti e ormai stabilizzati, aggiungendovi le gocce di un composto di tutt'altra origine. Un alchimista in trasferta, che si reca a rendere omaggio a dei colleghi talentuosi che lavorano su formule completamente diverse dalle sue - già celebri come Paul Simon e Lou Reed, come Neil Young e i Radiohead, o meno famosi come Elbow e Bon Iver, come Arcade Fire e Regina Spektor - ma solo a condizione che la sua visita sia gradita, e che ci sia un impegno a ricambiarla. Dietro Scratch My Back, infatti, c'è un patto già sottoscritto: a ogni rielaborazione contenuta nel disco seguirà, nei prossimi mesi, una replica a posizioni rovesciate, che confluirà in una raccolta "gemella" intitolata I'll Scratch Yours. Apparentemente uno scambio di cortesie. In realtà un esperimento.
eter non voleva mettersi alla prova. Voleva essere sorpreso. Riversare la sua voce in un contesto preesistente e osservare la reazione che si produceva in quella serie di alambicchi affascinanti e ormai stabilizzati, aggiungendovi le gocce di un composto di tutt'altra origine. Un alchimista in trasferta, che si reca a rendere omaggio a dei colleghi talentuosi che lavorano su formule completamente diverse dalle sue - già celebri come Paul Simon e Lou Reed, come Neil Young e i Radiohead, o meno famosi come Elbow e Bon Iver, come Arcade Fire e Regina Spektor - ma solo a condizione che la sua visita sia gradita, e che ci sia un impegno a ricambiarla. Dietro Scratch My Back, infatti, c'è un patto già sottoscritto: a ogni rielaborazione contenuta nel disco seguirà, nei prossimi mesi, una replica a posizioni rovesciate, che confluirà in una raccolta "gemella" intitolata I'll Scratch Yours. Apparentemente uno scambio di cortesie. In realtà un esperimento.«Ho esplorato alcune differenti idee di arrangiamento», si legge nelle note di copertina. E la parol
 a chiave è proprio quella: esplorato. La musica che viene incisa non è mai il solo punto di arrivo al quale si poteva pervenire muovendo da certe premesse: nella sua forma più alta ogni arrangiamento è una riscrittura, una reinvenzione che non si limita a clonare l'originale, ma che lo feconda in vista di una nuova nascita. Di un nuovo destino. Quello che credevamo un figlio unico ha almeno un fratello, e forse più di uno. Si assomigliano, ma non troppo. Si danno ragione d'istinto. Si contraddicono senza malanimo.
a chiave è proprio quella: esplorato. La musica che viene incisa non è mai il solo punto di arrivo al quale si poteva pervenire muovendo da certe premesse: nella sua forma più alta ogni arrangiamento è una riscrittura, una reinvenzione che non si limita a clonare l'originale, ma che lo feconda in vista di una nuova nascita. Di un nuovo destino. Quello che credevamo un figlio unico ha almeno un fratello, e forse più di uno. Si assomigliano, ma non troppo. Si danno ragione d'istinto. Si contraddicono senza malanimo.Alla fine, tra le tante possibili, la scelta di Peter Gabriel è stata drastica: niente chitarre e niente batteria. Via i capisaldi del pop, tanto per essere più sicuri (un po' più sicuri) di non lasciarsi tentare dalle soluzioni abituali. Sprigionare il ritmo appoggiandosi ai tamburi è troppo facile. Risultare accattivanti usando i soliti strumenti è quasi un sotterfugio. Il grande pubblico confonde la bellezza con la familiarità. Gli artisti, quelli veri, dovrebbero ricordargli che la familiarità è il riflesso di un'abitudine. Quasi sempre casuale. Spesso cattiva.
Niente chitarre e niente batteria. Al loro posto, un'orchestra. Fitta di archi e di ottoni. E guidata dal pianoforte. Quell'orchestra che nell'immaginario collettivo è l'università de
 lla musica; un concentrato di dignità; un crisma di autorevolezza. La migliore ambientazione possibile di quel racconto sonoro che è una grande melodia. Ma anche un equivoco, se non si sta attenti. Un'ambizione malriposta, per quei brani che siano nati, invece, per un'esecuzione semplificata. E di solito, infatti, quando il pop e il rock cedono alla tentazione di autocelebrarsi ergendosi in chiave sinfonica ne escono travolti e sbugiardati, come poveracci che abbiano rubato degli abiti di lusso e che ora, fatalmente, li indossino senza alcuna naturalezza. Con una goffaggine, o con un eccesso di compiacimento, che svelano il furto meglio di qualsiasi confessione.
lla musica; un concentrato di dignità; un crisma di autorevolezza. La migliore ambientazione possibile di quel racconto sonoro che è una grande melodia. Ma anche un equivoco, se non si sta attenti. Un'ambizione malriposta, per quei brani che siano nati, invece, per un'esecuzione semplificata. E di solito, infatti, quando il pop e il rock cedono alla tentazione di autocelebrarsi ergendosi in chiave sinfonica ne escono travolti e sbugiardati, come poveracci che abbiano rubato degli abiti di lusso e che ora, fatalmente, li indossino senza alcuna naturalezza. Con una goffaggine, o con un eccesso di compiacimento, che svelano il furto meglio di qualsiasi confessione.Peter Gabriel schiva la trappola. Non ha nessuna intenzione di sedurre con lo sfarzo. Non vuole fare leva su un singolo aspetto della costruzione che va innalzando, conscio che nell'opera d'arte ideale non c'è nulla che serva solo come prologo al colpo ad affett
 o. Nonostante l'orchestra - o grazie a questa specifica modalità di avvalersene - non c'è nulla di enfatico. Semmai il contrario. L'impressione che trasmette è quella di un uomo che stia cantando a occhi chiusi, totalmente assorbito dal tentativo di seguire il filo dei suoi pensieri - e delle sue emozioni.
o. Nonostante l'orchestra - o grazie a questa specifica modalità di avvalersene - non c'è nulla di enfatico. Semmai il contrario. L'impressione che trasmette è quella di un uomo che stia cantando a occhi chiusi, totalmente assorbito dal tentativo di seguire il filo dei suoi pensieri - e delle sue emozioni.I brani come ricordi lontani che riaffiorano a poco a poco. Gli orchestrali come amici discreti che assistono a questa meditazione solitaria, e muovendosi pian piano aggiungono un altro pezzetto di legno, o un altro granello di incenso, sul braciere che arde nella penombra.
Federico Zamboni, nato a Milano nel 1958 ma cresciuto a Roma, è giornalista e conduttore radiofonico. Tra il 1979 e il 1981, con lo pseudonimo di Claudio Fossati, ha tenuto una rubrica (quasi) fissa sul quindicinale “Linea”, dedicata a quella che allora si chiamava la “musica giovanile”. Dopo aver smesso di scrivere articoli per circa 15 anni, dedicandosi a tutt’altre cose, ha ripreso a pubblicare regolarmente nel 2000 su Ideazione.com. Attualmente, tra l’altro, cura la rubrica “Ad alto volume” sull’edizione domenicale del "Secolo d’Italia" e collabora al mensile “La voce del ribelle”, la rivista diretta da Massimo Fini.

Nessun commento:
Posta un commento