 Articolo di Domenico Paris
Articolo di Domenico Paris
Tiro fuori la lavatrice dal fortino dei mobili impilati alla parete. La muovo piano fino al centro della stanza, facendo attenzione a non staccare il tubo di scarico (ci mancherebbe!). Ecco, così: perfettamente in mezzo. Salgo sopra, piano, un passo alla volta per non cadere. Bene. La corda penzola dalla trave con oscillazioni minime. La stringo in un pugno per testarne la tenuta. Tiene. Mi terrà. Faccio il nodo con cura e me la provo intorno al collo. Stringo forte, fino a sentire i filamenti ruvidi della canapa che si intrudono nella pelle. Sì, ci siamo. Mi libero dalla stretta e scendo.
Tutto pronto, ormai. Quel che resta da fare è solo aspettare. Sì, okay, la decisione è presa, ma dopo quel che è stato - e più non sarà - ho bisogno di un’ispirazione come si deve. Dopo averlo cantato tante volte sui palchi inglesi e di mezza Europa, voglio sentirlo in tutta la sua forza, in tutta la sua essenza il momento che arriva. La fine è una firma da sprecarci anche due ghirigori in più, se serve. Ed io me lo sarò anche meritato un epitaffio come si deve, no? Anche se farò piangere tante persone. Anche se mi chiamo Ian Curtis e non ho ancora 24 anni. Anche se tra due giorni sarei dovuto partire con gli altri della band per il nostro primo tour negli Stati Uniti d’America. È che… basta, non voglio più tornarci.
Quello che servirebbe ora sono soltanto dei titoli di coda degni della circostanza. Nessun problema: prima di rientrare, sono stato al cinema a vedere La ballata di Stroszek e conservo nitide nella mente le immagini che ho avuto davanti agli occhi. Nere, perfettamente funebri. La migliore traduzione visiva dell’inferno che sento dentro. Rimane da sistemare il dettaglio dell’audio, ma se ci penso giusto un attimo, ho la soluzione a pochi metri di distanza. Vado in sala e metto sul piatto dello stereo The Idiot.
Sì, credo proprio che l’assalto sonoro del vecchio Iggy sia il requiem migliore che potessi sperare. L’ho amato così tanto! Aspetto che la musica prenda quota e mi abbandono alla danza folle che sembra avermi reso famoso un po’ ovunque. La cosa buffa - fino a un certo punto, però - è che la maggior parte della gente che viene ai nostri concerti non sa, non immagina che dietro questo mio apparente dimenarmi senza tregua ci siano degli spaventosi attacchi di epilessia. Mi si scambia, mi si è scambiato, per un eccezionale performer, un animale da palco che nessuno può tenere a bada, quando invece tutto quel che ho fatto non è stato altro che esorcizzare la sofferenza, cercando di scaricarla su ogni singola cellula e andare avanti, avanti.
Mah, meglio così, forse. Meglio venir ricordato come una specie di serpente in delirio che canta, piuttosto che come un incosciente che sfida il proprio male per elemosinare comprensione. Se c’è una cosa che non ho mai sopportato in questo mio passaggio sulla terra, è proprio questo: l’ipocrisia da quattro soldi che spinge le persone ad appestare con la propria sofferenza le vite degli altri. Centomila volte meglio lasciarsi consumare dal proprio dolore, dal cupio dissolvi, piuttosto che rubacchiare al destino un giorno ancora e trascinare la farsa della propria comparsa a tutti i costi (aspettando chissà cosa). No, io non sono così. Davvero, non lo sono mai stato.
Chi mi conosce, sa che in questi anni non ho scherzato neanche un secondo. Da quando i Joy Division si chiamavano ancora Warsaw e non erano che quattro ventenni incapaci di attaccare e finire insieme un brano, Ian Curtis non è cambiato di una virgola. Mai mi è passato per la mente di volere assurgere allo status di profeta generazionale o, peggio ancora, di simbolo attraverso il quale interpretare e decodificare un male comune. Mia, solo mia è stata quella sofferenza che ho tirato fuori per lo show. E tale deve rimanere. Non ho e non ho mai avuto niente da insegnare a nessuno, ma solo la nuda, innocente consapevolezza di dover raccontare la mia dignità di animale sofferente e ferito per sentirmi vivo fino a quando era lecito esserlo. Oltre, c’è un limite al di là del quale ci si riduce alla più spregevole delle pantomime. Un limite oltre il quale tutto quello che ci si incaponisce ad aggiungere non fa che screditare la bontà e la bellezza di quello che si è stati in grado di creare.
È per questo che ho deciso di farla finita. Non voglio diventare una macchina, non voglio diventare l’ennesima rockstar da trascinare in giro per il mondo, in giro tra la gente, ad inscenare spettacolini senza valore per gonfiare il portafoglio di qualcuno. E mi rifiuto, categoricamente, di continuare a far male alla mia famiglia, alle donne della mia vita, accampando la scusa delle mie pene. So che la piccola Nathalie, quando sarà grande, non riuscirà a capirmi fino in fondo (lo spero, soprattutto). Forse per lei sarò soltanto quel papà che l’ha abbandonata e se n’è andato via senza lasciar dietro niente. Mi piacerebbe poterle spiegare, invece, che quello che sto per fare sarà stato un atto necessario per consegnarle un’esistenza da vivere in pace, senza la sofferenza continua di dover fronteggiare le cadute e gli inferni di un uomo che ha toccato il fondo più estremo ed è incapace di risalire.
Deve essere mia, solo mia, la nave che affonda. Dovunque andrò, dovrà essere soltanto il mio quel cadavere che mi porterò dietro. E mia, soltanto mia la perdita definitiva di senso e di ragioni che mi spinge a dare le spalle al futuro. Vivi serena, bambina mia. Quando capirai appieno, spero potrai perdonare e scacciare il mio fantasma nell’angolo più remoto e polveroso della tua anima, assaporando estasiata ogni istante che il destino ti vorrà regalare. E lo stesso valga anche per te, Deborah. Quando decisi di andarmene, di fuggire con Annik, non era soltanto la nostra storia ad essere finita, ma io.
Tu lo sai, l’hai sempre saputo che non ce l’avrei fatta ad ingannarti, neanche un secondo. Continuare a provarci, continuare a far finta ci avrebbe fatto ancora più male. E avrebbe inficiato quella congiunzione di anime che per tanto tempo ci aveva tenuto così vicini, seppur tra mille problemi, ed era stata così unica da renderci felici. Ero già morto, tesoro. E non speravo certo che lei, invece che te, avrebbe potuto salvarmi. Non c’è salvezza, Debbie. Non ci si può fare niente. Love will tear us apart. L’Amore ci farà a pezzi. Ti ho amato, senza risparmiare un leptone di sentimento, ma ne ho pagato tutte le conseguenze e sono rimasto frantumato. Definitivamente sconfitto. “Le emozioni non cresceranno e noi stiamo cambiando i nostri modi di pensare, scegliendo strade differenti”.
È così che è andata, Debbie. Questa è la Verità, il definitivo approdo intellettuale e sentimentale -umano, in una parola- al quale sono arrivato e oltre il quale non so più andare. Capisci da sola che ormai siamo rimasti così, terribilmente lontani, e non è il caso, neanche un tentativo di più, di cercare impossibili ricongiunzioni con il rischio che tu poi possa stare ancora più male. Non è colpa di nessuno, cerca di andare avanti.
Sento che sto per avere un attacco. Devo sbrigarmi, non voglio morire rantolando sul pavimento o, peggio ancora, lottare qualche altro interminabile minuto con la vita e sfangarmela per l’ennesima volta con l’ennesimo pezzo di cuore in meno. Spengo lo stereo e le luci, e ripongo l’ellepì nella sua copertina. Me ne torno in cucina. Dalla finestra si vede il primo timido flash del mattino che cerca di bucare la cappa di grigio. Salgo sulla lavatrice e, nonostante gli spasmi incipienti, riesco a non inciampare. Mi rimetto il cappio intorno al collo e stringo. Rimane giusto un istante per guardarsi intorno nel semibuio della stanza e abbandonare gli ultimi pensieri al nuovo giorno. Ciao Bernard, ciao Peter, ciao Stephen. Non me ne vogliate. Ciao Annik. Non volevo ferirti. Addio Debbie, addio Nathalie. Dimenticate senza odiarmi.
Poi sto saltando.






















 Uno dei luoghi comuni sulla classe dirigente del secondo Novecento italiano è quello sulla sua formazione quasi eslusivamente dallle file dell'Ugi, l'Unione goliardica italiana di matrice laico-libertaria e risorgimen
Uno dei luoghi comuni sulla classe dirigente del secondo Novecento italiano è quello sulla sua formazione quasi eslusivamente dallle file dell'Ugi, l'Unione goliardica italiana di matrice laico-libertaria e risorgimen
























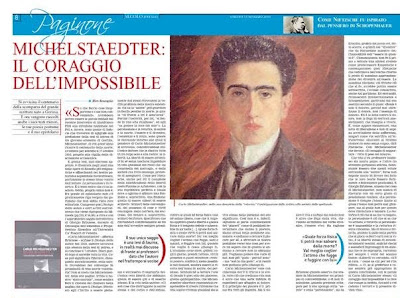 Articolo di Miro Renzaglia
Articolo di Miro Renzaglia






